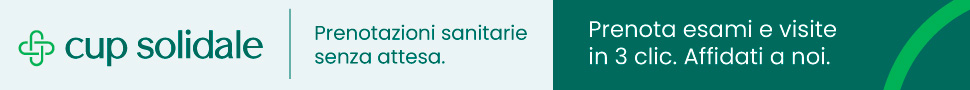I sintomi dell'appendicite possono variare e manifestarsi in forme diverse, influenzati dalla posizione e dalla dimensione dell'appendice. I sintomi iniziali negli adulti includono dolore al lato destro dell’addome o nella zona intorno all’ombelico, che inizia lievemente e, nell'arco di 24 ore, tende ad intensificarsi divenendo più acuto con il movimento, la palpazione o la respirazione.
Il dolore caratteristico dell’appendicite negli adulti, tuttavia, può non essere presente tra i sintomi iniziali che si manifestano nei bambini e neonati. In questi ultimi, infatti, il dolore tende a essere meno specifico e a interessare tutto l’addome.
Altri sintomi distintivi dell’appendicite includono:
- Dolore irradiato alla gamba destra, a causa della conseguente infiammazione del muscolo Psoas;
- Nausea e vomito;
- Aumento del numero di globuli bianchi;
- Febbre lieve, generalmente sotto i 38 gradi;
- Malessere generale;
- Perdita di appetito;
- Stitichezza o diarrea;
- Difficoltà nell’espellere i gas intestinali;
- Gonfiore addominale;
- Rigidità dell’addome;
- Dolore lombare, che può essere uno dei sintomi in caso appendicite retrocecale, condizione nota anche come appendicite nascosta o silenziosa.
Se questi sintomi comuni dell’appendice infiammata non vengono sottoposti all’attenzione di un medico ci possono essere alcune complicazioni. Una delle più temibili, seppur rare, è la rottura dell'appendice, che può evolvere in peritonite in 12-24 ore. In questo caso, i sintomi includono dolore più intenso, difficoltà ad effettuare movimenti e febbre superiore ai 38°C, mentre il trattamento richiede l’uso di antibiotici o drenaggio chirurgico.
Anche la formazione di un ascesso è una possibile complicanza dell’appendicite, che richiede lo stesso trattamento della peritonite.
In alcuni casi, condizioni come il colon irritabile, meteorismo, linfoadenite e problematiche all’ovaio, possono essere confusi con i sintomi iniziali dell’appendicite, in quanto la localizzazione del punto esatto in cui si manifesta il dolore può essere difficoltosa.
Inoltre, il dolore crampiforme causato da un attacco di appendicite può somigliare ai sintomi delle contrazioni uterine, che sono comuni durante la gravidanza. Man mano che la gravidanza progredisce, infatti, l'appendice viene spostata più in alto nell'addome, rendendo la localizzazione del dolore associato all'appendicite diversa da quella tipicamente attesa.
In uno stadio iniziale, è possibile alleviare i sintomi dell’infiammazione dell’appendice seguendo una dieta leggera ed evitando l’assunzione di bevande contenenti caffeina e alcol. Tuttavia, è sempre indicato consultare un medico prima di procedere autonomamente all’assunzione di eventuali farmaci antidolorifici o soluzioni terapiche per sfiammare l’appendice.